TIRA BRUTTA ARIA
Il Libro bianco della difesa di questo 2017 ha voluto por termine a molti equivoci. Il ministro ha dichiarato: “È un documento pensato per rendere più moderne ed efficienti le nostre Forze Armate e che per tre anni ha visto la collaborazione di esperti, think tank, università, centri studi, Parlamento e anche ONG. Un metodo totalmente nuovo rispetto al passato, che ci ha permesso di immaginare un modello di difesa e sicurezza capace di rispondere ai sempre nuovi rischi nazionali e internazionali.” Abbiamo più volte deriso la dicitura “Missioni di Pace” ed era ora di fare chiarezza; ma nella chiarezza è venuto meno qualcosa del vincolo sia morale sia giuridico che l’art. 11 della Costituzione, dicendo “ l’Italia ripudia” e non solo rinuncia alla guerra, poneva ai governi. Insomma, il vincolo resta ma è solo giuridico.
La partecipazione dell’Italia alle azioni militari è consentita nell’ambito della solidarietà e della giustizia internazionale, come strumento di difesa della libertà e dei diritti degli altri popoli, nel rispetto dei vincoli stabiliti nella Carta delle Nazioni Unite.
Opportunamente, l’ Articolo 11 non ha subito modifiche volte a legittimare le azioni di forza, nei confronti di stati in cui siano emerse emergenze umanitarie, con palese violazione dei diritti umani. (deportazioni, genocidi, stupri etnici). Anche se tali azioni di forza dovrebbero essere sempre condotte sotto l’egida di un’organizzazione internazionale, le emergenze sono risultate, a volte, strumentali al conseguimento di finalità economiche, di potere, di conquista e di offesa alla libertà dei popoli. Così, almeno, nella ex Yugoslavia, in Iraq e in Libia.
La costituzionalizzazione della possibilità di consentire alle limitazioni della sovranità, a condizioni di reciprocità ed uguaglianza con gli altri Stati, per un verso, segna la preminenza dell’interesse per la pace e la giustizia tra i popoli rispetto alla sovranità stessa, per un altro verso, legittima le limitazioni così motivate, escludendo ogni ipotesi di cessione.
Tuttavia, l’adesione a istituzioni sovranazionali che hanno per scopo un’integrazione via vai maggiore tra i popoli, porta con se l’ampliamento progressivo di queste limitazioni.. Così, attraverso una lettura deviata dell’Art. 11, si è passati dall’ingresso dell’Italia nell’Organizzazione delle Nazioni Unite al processo di integrazione europea, dove la mancanza di vigilanza della giustizia costituzionale ha condotto alla cessione della sovranità.
Personalmente, vedo implicazioni, gravissime, anzi a prima vista, direi, lesive della procedura di revisione costituzionale, scaturire dal Libro Bianco della Difesa sottoscritto il 10 febbraio dal ministro Pinotti, nei riguardi del principio pacifista recato dalla Costituzione, art. 11 in particolare. Perciò, all’allargamento del concetto di difesa della Patria, fino alla difesa di generici interessi nazionali in tutto il mondo e alla concomitante dislocazione dei nostri soldati nei Paesi baltici, alla frontiera russa, può fare eco questo bell’articolo di Matteo Zola, direttore di East Journal, dal titolo “Nel mirino di Putin”; un po’ orientato verso le tesi sostenute in ambito NATO. Matteo Zola apre dicendo: “Per l’Europa orientale, l’idea di NATO finora proposta da Trump è la peggiore notizia possibile” . Sappiamo come i paesi baltici abbiano fatto un caposaldo, tutto loro, dell’acquiescenza alla politica USA; ma la verità su quanto accade alle frontiere Nord della NATO, e anche dell’Unione europea, sta, a mio parere, in questo sottotitolo del testo: “ La NATO potrebbe rinunciare a futuri allargamenti a est, lasciando Ucraina e Georgia sotto la tutela russa, come contropartita per gli interessi americani in Medio Oriente.” Come dire, abbiamo perso in Siria e cerchiamo di rifarci, soffiando venti di guerra in Europa.

ADAM BERRY/GETTY
Quando nel 1862 Friedrich Reinhold Kreutzwald – umile figlio di servi della gleba – scrisse il Kalevipoeg non pensava di inventare una nazione. Egli voleva, certo, seguire le orme di MacPherson e dei suoi Canti di Ossian, dotando di un’epica la sua piccola patria baltica, l’Estonia, allora dominata dalla lingua tedesca. Ma la saga, che usava la povera lingua delle campagne, visse presto di vita propria e, benché nata dalla sola fantasia di Kreutzwald, venne unanimemente ritenuta antica, medievale testimonianza della vetustà della cultura estone, e assurta al rango di epos nazionale. Finalmente, grazie al Kalevipoeg (Il figlio di Kaleva, in italiano) anche gli estoni potevano vantare radici culturali remote e unirsi alle altre nazioni che, sulla scorta di epiche anticate, ma assai moderne, rivendicavano un proprio destino nel mondo. Il destino degli estoni venne presto messo alla prova quando, tra il 1918 e 1920, il paese dovette difendersi dalla doppia invasione tedesca e sovietica.
Il 23 giugno del 1919 l’esercito baltico sconfisse i due nemici, guadagnandosi l’indipendenza: sul campo di battaglia echeggiavano i versi del Kalevipoeg unendo così il sangue della battaglia a quello dell’eroe mitico. Da allora il 23 giugno è il Võidupüha, il giorno della Vittoria, ricorrenza che gli estoni hanno potuto tornare a festeggiare solo dal 1992, al termine della cattività sovietica. La parata cerimoniale è organizzata, come da tradizione, dalle Giovani Aquile, il corpo che raccoglie i ragazzi e le ragazze della Eesti Kaitseliit, la Lega per la Difesa estone, organizzazione paramilitare che ha il compito di difendere l’indipendenza del paese. Ogni 23 giugno i figli della patria sfilano con le bandiere in mano, fieri e impettiti nella loro divisa: non si tratta, però, di un gioco. La Eesti Kaitseliit conta più di venticinquemila volontari ben addestrati e armati dallo stato. Nel corso del 2016 il loro numero ha raggiunto i massimi storici, segnando alcune novità nell’addestramento quali l’apprendimento di tecniche di guerriglia e la costruzione di bombe fatte in casa utili a difendersi in caso di invasione da parte di un esercito regolare.
Da mesi l’Estonia vive infatti nell’incubo, e nella paranoia, di un’aggressione militare da parte russa. Gli eventi in Ucraina e l’annessione della Crimea hanno generato il panico nelle società baltiche, risvegliando antiche paure. Paure che, tuttavia, sono alimentate anche dalle recentissime notizie legate al nuovo inquilino della Casa Bianca, Donald Trump, il quale ha dichiarato che la NATO, sotto la sua guida, valuterà caso per caso se soccorrere stati membri che abbiano subito un’aggressione militare. L’Estonia, anche alla luce della sintonia che sembra esserci tra Putin e Trump, teme per il proprio futuro e corre ai ripari come può. Così giovani studenti e studentesse, artigiani e maestre, impiegati e operai arruolatisi nella Eesti Kaitseliit si trovano a essere moderni “figli di Kaleva”, chiamati a salvare l’indipendenza della patria ma impegnati in una partita che, a guardarla bene, è molto più grande di loro.
Il Baltico alla prova del Trumpismo
Non solo in Estonia: in tutte le tre repubbliche baltiche si respira un clima di tensione e incertezza. La Lettonia ha più volte invocato un maggiore impegno da parte della NATO ottenendo, al summit dell’Alleanza Atlantica tenutosi a Varsavia lo scorso luglio, il dispiegamento di forze armate di diverse nazionalità a presidio dei suoi confini. A partire da quest’anno saranno dislocate nel paese forze militari canadesi, italiane, portoghesi e polacche. In Estonia saranno inviati militari britannici mentre in Lituania saranno presenti forze armate tedesche. In Polonia la presenza militare NATO sarà formata da militari statunitensi. La presenza italiana al confine russo sarà particolarmente rilevante e, dal 2018, l’Italia sarà nazione guida nel VJTF, una task force di azione ultrarapida, “punta di lancia” in grado di intervenire in cinque giorni in caso di emergenza. Saranno quindi i soldati italiani a rispondere a un’eventuale – quanto improbabile – invasione russa del Baltico. L’incremento di militari NATO nel Baltico, per quanto limitato nei numeri, rappresenta il maggiore rafforzamento militare nell’area da venticinque anni a questa parte. Non può, e non deve, essere visto solo come un fatto simbolico.
 Immagine: la punta di lancia della NATO è formata da soldati provenienti da 23 paesi NATO: nella foto, soldati polacchi, estoni e slovacchi. Sean Gallup/Getty.
Immagine: la punta di lancia della NATO è formata da soldati provenienti da 23 paesi NATO: nella foto, soldati polacchi, estoni e slovacchi. Sean Gallup/Getty.
I timori baltici non sono infatti del tutto infondati. Secondo il capo delle forze armate lettoni, Raimonds Graube, dal 2014 le attività militari della Russia ai confini sono notevolmente aumentate. Le manovre navali russe nel mar Baltico e il passaggio – illegale e costante – di aerei militari di Mosca nei cieli lettoni, inquieta il governo di Riga che ha approvato a fine febbraio modifiche alla legge sulla sicurezza nazionale rafforzando e semplificando le procedure in caso di minaccia. Una di queste misure prevede che le istituzioni del paese non possano vietare all’esercito di combattere in caso di attacco militare in territorio nazionale. Insomma, il parlamento ha deciso di dare più poteri all’esercito, un chiaro segnale di irrequietezza.
Inoltre, la recente “legge sulla lealtà” rischia di dare il via a pericolose epurazioni di insegnanti, docenti universitari, dirigenti scolastici, che si dimostrino “sleali” verso lo stato. Approvata lo scorso 2 dicembre insieme alla legge sull’educazione, è il frutto delle psicosi della società lettone. Come scritto dalla slavista Laura Luciani: “In un paese tradizionalmente diviso su questioni di ordine storico, sul lascito dell’epoca sovietica e sul rapporto alla lingua e all’identità nazionale, una legge che prescrive la ‘lealtà’ allo stato è sintomo – più che della volontà di proteggere la sicurezza nazionale – di un approccio politico che ancora rifiuta di superare una certa diffidenza nei confronti di parte della popolazione”. Ovvero della minoranza russa del paese che rappresenta il 27% circa della demografia.
Secondo il capo delle forze armate lettoni, Raimonds Graube, dal 2014 le attività militari della Russia ai confini sono notevolmente aumentate (Vuol dire tutto e niente, ma da chi viene detto? ndr).
Una piccola parte di loro è senza cittadinanza, si tratta dei cosidetti nepilsoņi, persone che dopo l’indipendenza della Lettonia, nel 1991, non hanno superato il test linguistico necessario per diventare cittadini lettoni. Benché siano appena 400mila, i nepilsoņi sono diventati lo strumento principale della propaganda filorussa nel paese. Il partito Par Dzimto Valodu! (letteralmente, Per la lingua madre!) guidato dall’attivista russofilo Vladimirs Lindermans, si batte da anni per il riconoscimento dei diritti politici dei nepilsoņi e per l’indipendenza del Latgale, regione orientale del paese a maggioranza russa. Il partito ha goduto dell’appoggio del Cremlino per alcuni anni, fin quando la crisi ucraina e l’annessione della Crimea hanno ridotto al minimo la tolleranza nei confronti di potenziali “nemici” interni. La magistratura lettone è quindi intervenuta nel febbraio scorso dichiarando illegale il partito e imponendone lo scioglimento.
A seguito della sentenza, Vladimir Putin intervenne impegnandosi a “difendere la minoranza russa del Latgale” confermando implicitamente i timori di ingerenza russa nel paese. In particolare i sospetti che Mosca possa alimentare una sollevazione nella regione – o crearne una ad arte – al fine di intervenire militarmente, come già in Crimea, sono diventati sempre più concreti per gli osservatori locali. Le preoccupazioni sono decisamente aumentate dopo l’elezione di Donald Trump. Quel che si teme è che la NATO non reagisca a un’eventuale ingerenza russa. Intanto, l’arrivo di forze armate internazionali al confine lettone ha suscitato indignazione tra la popolazione russofona del Latgale che le percepisce come truppe di occupazione, mandate lì per controllare loro piuttosto che il confine. Il rischio maggiore, per la Lettonia e per il Baltico, è che la paura per l’invasione diventi una self-fulfilling prophecy, una profezia che si auto-avvera.
I missili a Kaliningrad
Quando Immanuel Kant diede alle stampe Per la pace perpetua, nel 1795, non poteva certo immaginare che la barbarie della Seconda guerra mondiale avrebbe trasformato la sua Königsberg in un cumulo di macerie dalle quali sarebbe sorta – in ottemperanza ai dettami del realismo sovietico – la nuova Kaliningrad, avamposto russo della guerra nucleare. L’enclave di Kaliningrad ospita infatti alcune batterie di missili nucleari Iskander-M, recentemente dislocate malgrado i trattati internazionali vietino espressamente lo spiegamento di missili nucleari entro i 500 chilometri dal confine dell’Unione Europea. I governi di Varsavia e Vilnius sono subito entrati in fibrillazione, accusando Mosca di voler aumentare la tensione sul confine orientale.
La NATO potrebbe rinunciare a futuri allargamenti a est, lasciando Ucraina e Georgia sotto la tutela russa, come contropartita per gli interessi americani in Medio Oriente.
Tuttavia quella dei missili è una partita che si gioca da anni, cominciata con lo “scudo spaziale” voluto da George W. Bush e portata avanti, seppur in tono minore, dall’amministrazione Obama. Una partita che ha visto anzitutto il dispiegamento di missili americani Patriot in Repubblica Ceca e Polonia – paesi tradizionalmente antirussi – e successivamente in Romania. Mosca rispose allora alla provocazione installando missili nucleari nel suo avamposto prussiano. La situazione si normalizzò solo nel 2010, con la firma del Trattato “New Start”, che prevedeva una riduzione delle testate nucleari e l’accantonamento del progetto di “scudo antimissile” americano. La distensione non è durata molto e la crisi ucraina ha riacceso la competizione tra Russia e Occidente. Una competizione che non giova alla pace e in molti sperano proprio nel nuovo presidente americano per trovare una soluzione alle tensioni tra Mosca e Washington.
La speranza è un fungo velenoso, diceva Bukowski, ma è sempre meglio di un fungo atomico, così non resta che fare affidamento proprio su Trump, il quale – qualora la sua amicizia con il Cremlino vada oltre le cortesie mediatiche e le premure degli hacker – potrebbe favorire il disarmo. Speranze forse mal risposte se diamo credito al recente tweet prenatalizio con cui Donald J. Trump ha gelato gli animi delle cancellerie internazionali: “Gli Stati Uniti devono espandere il proprio arsenale nucleare”. Così, in attesa che qualche ordigno ‘fine-di-mondo’ torni a scaldare il clima politico, non resta che attendere di vedere quali saranno le reali azioni del nuovo presidente il quale dovrà, giocoforza, affrontare il vero vulnus dell’Europa orientale, il conflitto ucraino.
L’Ucraina e i destini siriani
A fare le spese dell’amicizia tra Trump e Putin sarà probabilmente l’Ucraina. Il conflitto nel Donbass, regione orientale del paese, è uscito dalle pagine dei giornali ma non ha smesso di seminare morte. Gli scontri si riaccendono periodicamente, talvolta in modo circoscritto, talaltra attorno a obiettivi militari sensibili, come lo snodo ferroviario di Debaltsevo, con massicci dispiegamenti di forze. Si calcola che dall’agosto scorso la tregua sia stata interrotta ben 350 volte. A farne le spese è la popolazione civile. Gli accordi di Minsk, nella loro seconda edizione del febbraio 2015, prevedevano la cessazione delle ostilità in attesa di una riforma costituzionale che garantisse autonomia alle repubbliche separatiste di Donetsk e Lugansk, consentendo infine all’Ucraina di riprendere il controllo delle regioni contese. Tuttavia il governo di Kiev ha finora evitato qualsiasi riforma in tal senso ritenendola – non a torto – la premessa “legale” per una futura dichiarazione di indipendenza delle regioni orientali. Inoltre gli accordi di Minsk non stabilivano le sorti della Crimea, illegalmente occupata dai russi.

Immagine: T72 filorussi in riposo a Torez, nella regione di Donetsk. Aleksey Filippov/AFP/Getty.
A fronte dell’immobilismo che regna sul fronte ucraino, la soluzione della crisi sembra passare necessariamente da Damasco. L’intervento russo a fianco di al-Assad ha fatto del conflitto in Donbass un evento secondario per le cancellerie internazionali, eppure legato ad esso. L’intreccio tra le crisi siriana e ucraina è soprattutto geopolitico: alla Russia interessa il possesso della Crimea, quale sbocco sul Mediterraneo, tanto quanto il controllo del porto di Tartus, in Siria, che al-Assad aveva messo nelle disponibilità di Mosca. A Tartus i russi progettano di costruire una base navale permanente ma già oggi i russi usano Tartus a scopi militari, benché la destinazione d’uso ufficiale sia quella di “punto di supporto tecnico”.
Tartus è un approdo fondamentale per Mosca poiché consente di aggirare lo storico ostacolo del Bosforo: dai capisaldi di Sebastopoli e Tartus dipende quella proiezione sul Mediterraneo che i russi cercano da almeno due secoli. Solo dopo che si sarà trovata una soluzione per la Siria, e alla luce dei rapporti di forza che tale soluzione produrrà, sarà possibile immaginare un esito per l’Ucraina. Ed è possibile che sul piatto della bilancia siriano ci finisca anche Kiev, quale contropartita per una pacificazione che veda l’uscita di scena di al-Assad o una federalizzazione della Siria. E di nuovo entra in scena la NATO che, sotto la guida di Donald Trump, potrebbe rinunciare a futuri allargamenti a est, lasciando Ucraina e Georgia sotto la tutela russa, avendo come contropartita una garanzia per gli interessi americani in Medio Oriente.
Nonostante le aperture nei confronti del paese, i vertici UE continuano a ripetere che “non è stata fatta alcuna promessa” in merito a una futura adesione della Moldavia all’Unione.
Tuttavia, se la situazione nel Donbass sembra destinata a trovare una soluzione, diversi sembrano essere i destini della Crimea. “Con l’annessione alla Russia, la questione della Crimea aumenta il proprio livello di intrattabilità – scrive Davide Denti, ricercatore dell’Università di Trento – passando dalla fase di stato a limitato riconoscimento (come i vicini post-sovietici di Transnistria, Abcasia, e Ossezia del Sud) alla fase di espansione territoriale di uno stato tramite uso o minaccia illegale della forza ed occupazione militare, come nel caso del Sahara Occidentale occupato dal Marocco, dei territori palestinesi occupati da Israele, o di Cipro Nord occupato dalla Turchia. Questo sviluppo è contrario ai più fondamentali principi del diritto internazionale (ius cogens, o norme perentorie/imperative), e pertanto tutti gli altri stati ONU sono legalmente obbligati a non riconoscerne gli effetti giuridici”. Nel migliore dei casi la Crimea resterà russa de facto ma rappresenterà sempre un oggetto di contesa, un casus belli per futuri conflitti, con il rischio di trasformarsi nel lungo periodo in una spina nel fianco di Mosca. L’avvento di Trump, che ha definito l’ONU un “club dove si fanno solo chiacchiere”, potrebbe aprire una fase di minore attenzione alla legalità internazionale, favorendo gli interessi russi sulla Crimea e congelando la situazione; tuttavia, Trump non sarà presidente a vita, né potrà comportarsi da padrone del mondo. La questione della Crimea è solo rimandata.
La Moldavia contesa
Nel 1987 un pasciuto signore, mentre sedeva assopito alla sua scrivania, con una bottiglia di vodka nel cassetto, si vide recapitare una missiva con il timbro della direzione centrale dell’Elektromaš, azienda energetica dell’Unione Sovietica. È una promozione, ma anche un trasferimento dalla centrale idroelettrica di Nova Kachovka, in Ucraina, dove ricopriva il ruolo di assistente direttore, a Tiraspol, in Moldavia, con il compito di dirigere la sezione locale del gruppo Elektromaš. Così, l’ingegnere Igor Nikolaevich Smirnov, fa di nuovo le valigie. Lui, che proveniva da Petropavlovsk-Kamčatskij, remota città all’estremo oriente della Russia, fondata da Bering due secoli prima, ne aveva fatta di strada: figlio di un “nemico del popolo”, trascorse un’infanzia difficile che solo la morte di Stalin rasserenò, reintegrando la famiglia nella collettività sovietica. Diplomatosi all’istituto meccanico, fece carriera all’Elektromaš guadagnandosi l’appellativo di “sceriffo” per il suo fare rude.
Giunto a Tiraspol entrò a far parte della nomenclatura locale, tutta di origine russa. La Moldavia è infatti un paese di lingua romena che, nel periodo sovietico, fu oggetto di una lenta e costante russificazione. I quadri locali del partito erano tutti russi, come russa era la classe dirigente. Tiraspol, città industriale, era una città quasi totalmente russa, con una massiccia presenza di ucraini. Il pasciuto e rude sceriffo Smirnov si trovò a essere presto un feudatario di provincia, e in soli due anni divenne presidente del soviet cittadino. Da quella posizione, nel 1991, proclamò l’indipendenza della regione al di là del Dniestr (Transnistria, appunto). Ne scaturì una guerra con la Moldavia, che nel frattempo si era dichiarata indipendente dall’URSS. Lo scontro fu impari: il 14° battaglione dell’Armata Rossa, che nella città di Tiraspol controllava il più grosso arsenale d’armi del continente, si schierò a difesa degli indipendentisti transnistriani ed ebbe vita facile contro l’inesperto esercito moldavo.
Le ragioni dello scontro furono principalmente etniche. Il processo di unificazione ed identificazione nazionale della Moldavia passa storicamente attraverso un’omologazione culturale e linguistica imposta dalle élites russe. L’idioma moldavo fu letteralmente inventato nel 1924, quando, in seguito all’occupazione dei territori della Bessarabia da parte dei sovietici, venne imposto l’uso dei caratteri cirillici in sostituzione di quelli latini, per sottolinearne le differenze con il romeno, ed enfatizzare l’influsso letterario e linguistico russo. In realtà non esiste differenza tra romeno e moldavo, se non un diverso segno grafico, una forte influenza della lingua russa maturata durante un periodo d’occupazione che si è protratto per quasi 70 anni, e un’ossessione ideologica imposta a rimarcare la superiorità sulla cultura romena.
Tuttavia la Moldavia è stata, insieme alla Valacchia, il nucleo originario della nazione romena e questo spiega da un lato la vicinanza (se non identità) culturale con la Romania e, dall’altro, il forte tentativo di russificare la regione durante il regime comunista. L’identità romena della Moldavia è sopravvissuta durante il regime sovietico e verso la fine degli anni Ottanta il governo della Repubblica Socialista Sovietica Moldava, sempre più libero dal giogo di Mosca, decise di dare un taglio al passato e ripristinare l’utilizzo dei caratteri latini. Fu il segno che qualcosa stava cambiando e che i russi, minoranza nel paese ma da sempre al potere, stavano perdendo la presa sul paese. Fu allora che un gruppo di industriali di origine russa, capeggiati proprio da Igor Smirnov, decise di scendere in piazza e proclamare lo sciopero generale e l’indipendenza della regione.
Da allora la Transnistria è lì, riconosciuta solo da Mosca, con le truppe russe a garantirne la sovranità e la falce e martello sulla bandiera. Lungo le rive del fiume Nistro corre oggi una frontiera che separa due mondi e due epoche. Da un lato la Moldavia, che guarda all’Unione Europea e cerca di avvicinarsi, persino di annettersi, alla Romania; dall’altro la Transnistria, con le sue kommunalki scalcinate, le vecchie automobili Dacia ammaccate dal tempo, le bandiere rosse alle fermate degli autobus. La frontiera è garantita da una buffer zone di 50 chilometri ma ogni tanto qualche sparatoria riaccende gli animi. Inevitabilmente, le politiche a stelle e strisce nei confronti dell’Ucraina avranno ricadute significative anche qui.
Interessata dalla nuova competizione tra Mosca e Washington è tutta la fascia che un tempo separava mondo sovietico ed Europa, dove i conflitti latenti e le questioni irrisolte (se qualcuno vuole.ndr) possono facilmente diventare strumenti di disordine e instabilità.
Oggi la Moldavia si trova stretta tra due poli di attrazione, Russia e UE, mostrando tuttavia una tiepida preferenza verso l’integrazione europea che l’ha portata a siglare, nel 2014, un Accordo di associazione con Bruxelles dal quale sperava di risanare almeno in parte la propria disastrata economia. L’avvicinamento moldavo all’Unione Europea ha subito allarmato Mosca, i cui malumori nei confronti dell’Accordo di associazione e di libero scambio non hanno tardato a farsi sentire. La stipula dell’accordo, infatti, è stata interpretata dal Cremlino come un tentativo dell’UE di aggiudicarsi l’esclusiva sulla Moldavia, rivelando ancora una volta il forte interesse russo nel mantenere il controllo dello spazio post-sovietico. La pessima gestione dei partiti liberali al governo, di marca filo-europea, unitamente alle ruberie e agli scandali giudiziari della classe politica, hanno spinto l’elettorato verso “uomini nuovi” strettamente legati al Cremlino, come Igor Dodon, fresco Presidente della Repubblica, la cui immagine mentre stringe la mano a Vladimir Putin ha campeggiato grandiosamente su tutti i manifesti elettorali mostrando chiaramente quali fossero i destini del paese in caso di una sua vittoria. Una volta eletto, Dodon ha promesso di stracciare l’Accordo di associazione con l’UE e risolvere l’annoso problema della Transnistria. Commentando la vittoria di Trump, il presidente Dodon ha dichiarato che “finalmente gli americani hanno messo fine all’imperialismo liberale” e che “una nuova stagione di rapporti con la Russia deve aprirsi”.
Preda di una grave crisi economica, la Moldavia è un paese conteso tra Occidente e Russia, in cui la società è divisa tra il progetto europeo e quello euroasiatico. I destini europei della Moldavia potrebbero essere messi fortemente in discussione qualora l’amministrazione americana targata Trump decidesse di ritirarsi dall’Europa orientale. L’Unione Europea, da sola, non sembra possedere adeguati strumenti di persuasione nei confronti dell’opinione pubblica moldava, e l’immagine appannata di Bruxelles non attrae più come un tempo. Anche da parte europea c’è freddezza e il cammino della Moldavia verso l’UE resta una prospettiva lontana. Nonostante le aperture nei confronti del paese, i vertici UE continuano a ripetere che “non è stata fatta alcuna promessa” in merito a una futura adesione della Moldavia all’Unione. La cautela europea è d’obbligo, visti i passi falsi compiuti in Ucraina, ma è anche il segno dell’incertezza che l’avvento di Trump ha diffuso nel vecchio continente.
Georgia, la tensione corre sul filo
Un enorme cartellone accoglie chi entra a Tbilisi dalla Kakheti Highway, arteria d’asfalto che collega il centro città all’aeroporto. Moderni soldati armati fino ai denti campeggiano sul manifesto, alle loro spalle sventolano la bandiera georgiana e quella della NATO. A pochi chilometri si trova infatti la base militare di Vaziani dove, dal 2008, truppe americane addestrano i malandati militari georgiani. La collaborazione militare tra Stati Uniti e Georgia si è intensificata a seguito della guerra osseto-georgiana del 2008, durante la quale l’esercito georgiano crollò sotto i poderosi colpi delle truppe russe che, in soli cinque giorni, arrivarono alla porte di Tbilisi. Dal 2014, a seguito degli accordi presi al vertice NATO tenutosi in Galles nello stesso anno, le truppe NATO hanno sostituito quelle americane allo scopo di compiere esercitazioni militari congiunte nell’area caucasica.
Durante lo stesso summit venne anche firmata un’intesa con l’Ucraina, dimostrando ancora una volta quanto lo scacchiere dell’Europa orientale sia importante per l’Alleanza Atlantica. Georgia e Ucraina hanno condiviso gran parte delle vicende politiche degli ultimi anni: entrambi i paesi sono stati teatro di una rivoluzione colorata, entrambi i paesi hanno cercato di uscire dalla sfera di Mosca ed entrambi i paesi sono stati invasi da truppe russe. Infine, sia Tbilisi che Kiev, hanno siglato un Accordo di associazione con l’UE, creando un’area di libero scambio con l’Europa. Come nel caso moldavo e ucraino, anche la Georgia si trova amputata di una parte del proprio territorio: l’Abcasia e l’Ossezia del Sud sono repubbliche indipendenti de facto, controllate dal Cremlino, che le usa come strumento per destabilizzare lo stato georgiano.

I preparativi per l’arrivo del senatore John McCain al Centro di addestramento e valutazione NATO-Georgia a Krtsanisi, poco lontano da Tbilisi. Vano Shlamov/AFP/Getty.
In particolare il confine con l’Ossezia del Sud è oggetto di continue provocazioni da parte russa: spostando nottetempo la frontiera, le forze russo-ossete inglobano lentamente ma inesorabilmente case, pascoli, persino interi villaggi. Una provocazione cui l’esercito georgiano non può rispondere, consapevole che sarebbe la miccia per una nuova escalation militare. Durante la guerra del 2008, la Georgia ha capito di non poter contare sull’aiuto di Washington in caso di conflitto, ed è probabile che con l’avvento dell’amministrazione Trump si troverà a doversela cavare da sola. La politica di allargamento della NATO verso il Caucaso era stata infatti portata avanti da Hillary Clinton nel suo ruolo di Segretario di Stato, in un disegno politico e diplomatico che sembra essere all’opposto di quello prefigurato da Trump.
Lo scontro per la Casa Bianca tra Donald Trump e Hillary Clinton è stato vissuto, nell’Europa orientale, come un passaggio epocale, un appuntamento con il destino. Un destino cinico e baro che – con la vittoria di Trump – obbliga gran parte della regione a rivedere la propria politica estera e le proprie priorità. Tuttavia, l’eventuale ritiro degli Stati Uniti e della NATO dall’Europa orientale potrebbe dare la stura ai mai sopiti nazionalismi, favoriti dalle retoriche dell’accerchiamento e della difesa della patria, creando le premesse per nuove tensioni politiche e militari nella regione con l’effetto collaterale di complicare ulteriormente la vita all’Unione Europea, che già fatica a contenere i revanscismi polacco e ungherese.
Un ribollire di inquietudini
A essere interessata dalla nuova competizione tra Mosca e Washington è tutta la fascia che un tempo separava mondo sovietico ed Europa, dove i conflitti latenti e le questioni irrisolte possono facilmente diventare strumenti di disordine e instabilità.
Dal Baltico al mar Nero è un ribollire di inquietudini, uno sbuffare di pressioni, un vociare querulo e isterico che si agita sotto una calma del tutto apparente. Le vecchie fratture sociali, le irrisolte disuguaglianze economiche, le eredità del periodo sovietico, le memorie della russificazione, i separatismi latenti, i riscoperti epos nazionali, sono tutti elementi pirici – solitamente inerti – ma esplosivi se agitati da fattori esterni. La tensione crescente trova riscontro anche nell’acquisto di armi che, dal 2014 ad oggi, ha segnato nell’Europa orientale un incremento di spesa pari a 12 milioni di dollari, a fronte di una contenimento nell’Europa occidentale (SIPRI). Non abbastanza per parlare di corsa agli armamenti ma sufficiente a testimoniare il clima di inquietudine della regione.
Questo è lo scenario su cui si affaccia la nuova amministrazione americana made in Trump. L’augurio è che trionfino lucidità e realismo politico, e che gli allarmismi che si sono accompagnati all’elezione del nuovo presidente americano si dimostrino infondati. Gli Stati Uniti hanno dimostrato, specialmente dal dopoguerra in poi, una forte continuità in politica estera ed è lecito attendersi che, malgrado i proclami, l’amministrazione Trump prosegua sulla linea tracciata. Una linea che può anche passare da una distensione con Mosca ma che difficilmente accetterebbe arretramenti sui fronti aperti. L’avvento di Trump rappresenta forse la più grande incognita politica degli ultimi venticinque anni, ovvero dalla caduta del Muro, e non solo per l’Europa orientale. Prima di scandire il penitenziagite bisognerà dare il tempo al nuovo presidente di mostrare le sue vere intenzioni. Certo l’Europa orientale ha bisogno di stabilità, e una distensione con Mosca non potrà che giovare: l’importante è che la sovranità politica e l’indipendenza dei piccoli paesi di confine non venga sacrificata sull’altare di una spartizione del mondo mascherata da pacificazione.
Matteo Zola, direttore responsabile di East Journal










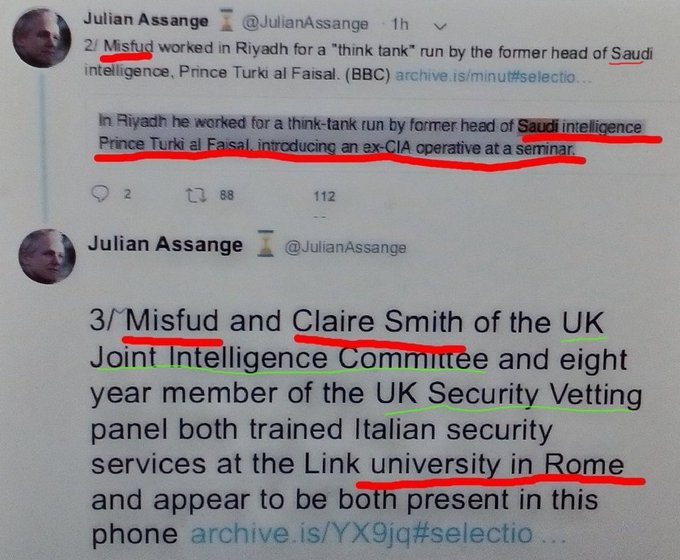

















 Immagine: la punta di lancia della NATO è formata da soldati provenienti da 23 paesi NATO: nella foto, soldati polacchi, estoni e slovacchi. Sean Gallup/Getty.
Immagine: la punta di lancia della NATO è formata da soldati provenienti da 23 paesi NATO: nella foto, soldati polacchi, estoni e slovacchi. Sean Gallup/Getty.







